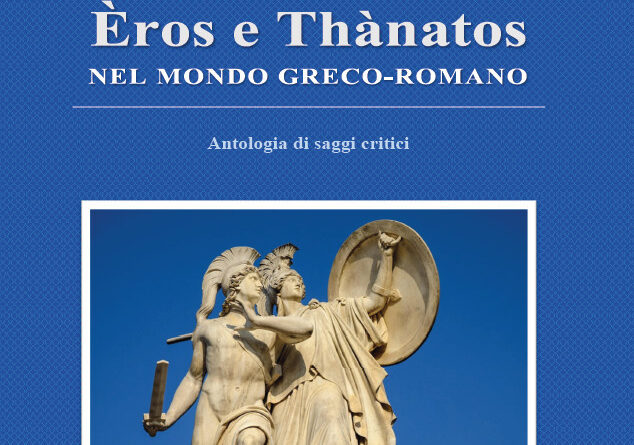È uscito il libro di saggistica: Èros e Thànatos nel mondo greco-romano di Gabriella Carrano con premessa di Enzo Concardi
Comunicato Stampa
Pubblicata l’antologia di saggi critici “Èros e Thànatos nel mondo greco-romano” di Gabriella Carrano, con premessa di Enzo Concrdi, Guido Miano Editore, Milano 2025
Sono sei i saggi critici di questa antologia, visitatrice del mondo culturale e ideologico ellenico e latino, ad opera della studiosa Gabriella Carrano, sulla tematica complessiva riguardante alcuni aspetti di Èros e Thànatos nel mondo greco e romano. Maggiori specificazioni sulla materia trattata emergono dalla suddivisione in capitoli dell’opera, ripartizione che delinea autori, periodi, linee di pensiero, tendenze, contenuti, stili: al centro vi è essenzialmente il teatro, non solo come genere letterario, ma soprattutto come specchio delle società, sulle cui concezioni e realizzazioni si è poi sviluppata la civiltà occidentale. Occorre leggere innanzitutto l’indice, poiché ci guida a penetrare più da vicino i messaggi che la Carrano vuol trasmettere circa la pòlis greca, l’Urbe romana, la condizione femminile in quei contesti, la carrellata degli autori – non solo teatrali – che hanno scritto testi significativi al riguardo, i rapporti con la dimensione mitologica, le sue considerazioni e i suoi giudizi di merito e di valore, con acute comparazioni tra loro ed anche con raffronti motivati con i secoli successivi fino alla contemporaneità.
Ecco dunque la sequela: 1. Le origini della tragedia e del tragico: le riflessioni di Mario Untersteiner; 2. Èros e Thànatos nell’èpos: il desiderio e il dramma della conoscenza nella trasfigurazione di Ulisse. Il viaggio dell’ulisside tra aretè ed entropia planetaria: l’inattingibile limen di un centro ‘periferico’; 3. Patogenesi dell’Eros al femminile nell’universalità del dramma classico. Fedra, Medea, Didone: tragedie di passione, passioni della storia; 4. Il fiore di Nosside in terra locrese: balsami alessandrini per una mistica della femminilità; 5. Ovidio e le pratiche abortive: èthos elegiaco e scientia ellenistica in Lucrezio e negli elegiaci; 6. La meditatio mortis senecana tra finis e transitus: i traslati del lessico dell’interiorità.
Come si evince già da tali input culturali il linguaggio dei vari saggi è spesso rigorosamente tecnico, specialistico, per addetti ai lavori, se non addirittura – talvolta – criptico ed esoterico: ciò, tuttavia, a mio parere, conferisce maggiore fascino alla narrazione, che ci conduce nell’avvincente viaggio nei mondi in questione, per molti purtroppo dimenticati: il lettore che naviga nelle dimensioni essoteriche, potrà approfondire con ricerche personali. Ecco un lacerto in cui prevale um linguaggio iniziatico: «Gli epigrammi di Nosside di Locri Epizefiri rappresentano un unicum nel panorama delle “avventure” femminili del tardoantico, non solo per la ripresa tutta “decadente” di stilemi saffici in una lingua intrisa di dorismi e di ricercatezze modellate sugli epicismi, ma anche per le robuste ibridazioni del genere epigrammatico con l’ilarotragedia del fliacografo Rintone di Taranto (Antologia Palatina, VII, 718)» (dalla Premessa al saggio Il fiore di Nosside in terra locrese). Inoltre occorre aggiungere la ricca dote di note culturali esplicative che il libro vanta, gli inserimenti di terminologie in latino e greco direttamente nei testi senza traduzioni, ed invece brani autoriali di varie dimensioni con traduzione a fianco.
Va sottolineata ancora l’importanza e l’influenza che il concetto dualistico di Èros e Thànatos, ovvero la pulsione di vita e la pulsione di morte, ha esercitato ed esercita sulla cultura europea, in primis nel pensiero freudiano e, in particolare, nel suo saggio Al di là del principio di piacere (1920). Qui il
fondatore della psicanalisi fa riferimento ad Empedocle di Agrigento, la cui dottrina «[…] si avvicina talmente alla dottrina psicanalitica delle pulsioni, da indurci nella tentazione di affermare che le due dottrine sarebbero identiche». E Freud afferma che «[…] i due principi fondamentali di Empedocle – philìa (amore, amicizia) e nèikos (discordia, odio) – […] sono la stessa cosa delle nostre due pulsioni Èros e Distruzione». Basterebbe solo ciò, sempre a mio parere, per invogliare a leggere il libro della Carrano e per prendere coscienza di quanto sia grande il nostro debito nei confronti delle radici greco-latine.
Ora, in forma forzatamente sintetica, chiudiamo tale premessa indicando al lettore i punti forti dei sei saggi critici: autori, tematiche e altro all’occorrenza. La Carrano sottolinea l’importanza del teatro greco per l’Atene classica, come una cerimonia di tipo religioso con valenze sociali e politiche. In Sofocle la tirannide è argomento primario. Per Aristotele la tragedia è evento catartico e panellenico che ha origine dal ditirambo (forma di lirica corale). La tragedia fa propria la materia mitologica. Gli apporti di Eschilo, Sofocle, Euripide sul ruolo femminile: Clitennestra, la donna virago dominante e regina assassina; il logocentrismo maschile da lei avversato; la ribellione al ruolo tradizionale; in Antigone, Elettra, Aiace la sottomissione della donna nella società greca, mercificata, dedita alla procreazione, in clausura, vittima della misoginia, il cui corpo è proprietà maschile. Domina «l’impero del maschio sulla donna nel mondo greco» (Introduzione, p.50).
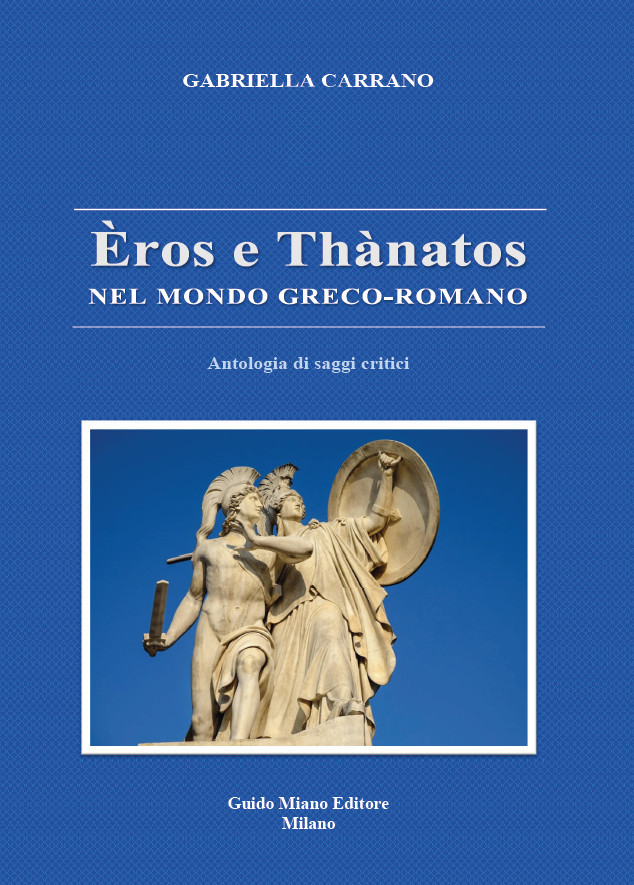
Si passa al viaggio di Ulisse in Omero e in Dante, rimarcando il protagonismo della figura e dell’èpos dell’Ulìsside nel corso dei secoli, con molteplici riferimenti ad autori moderni, tra cui Leopardi, D’Annunzio, Pirandello, Joyce, Pascoli, Ungaretti, Saba, Mann, Eliot, Quasimodo, Primo Levi. Si ritorna alle grandi passioni del teatro classico con le vicende drammatiche di tre donne e con la conclusione riassuntiva della Carrano: «La disamina delle “passioni” di Fedra, Medea e Didone lascia spazio ad un’unica verità, adamantina ma tragica: l’amore di queste donne è delirio e vergogna, grido e silenzio, rovina e abbandono, consapevolezza e stratagemma, amore e odio, dignità e negazione della dignità».
Si varca l’Egeo per sbarcare nella Magna Grecia, dove l’autrice ci fa conoscere la lirica graziosa ed elegante di Nosside di Locri (III secolo a.C.), seguace di Saffo, il cui canto si pone in contrapposizione agli inni guerreschi. Infatti, come sottolinea la Carrano, «[…] la poesia di Nosside è il canto d’amore delle aristocratiche di Locri in una lingua espressiva, robusta ed “imagista” (linguaggio conciso, chiaro, essenziale, scarno… inciso mio) quale il dialetto dorico». Nella società della Locride di quel tempo la donna aveva un ruolo importante: vigeva una sorta di matriarcato. Oggi vi è ancora memoria dell’antica colonia, in quanto è stato istituito il “Premio Internazionale Nosside di Poesia” con il patrocinio Unesco.
Poi entriamo nel mondo romano antico con il saggio che vede Ovidio contro le pratiche abortive, tema di assoluta modernità. Egli si oppone nel nome di un nuovo èthos, contrapposto alle dottrine ellenizzanti di stampo “libertino e cortigiano”; come specifica ancora la Carrano: «[…] fides e pudicitia brillano, nella rivendicazione dell’eros coniugale, contro luxuria e cultus, così come la Roma evandrea diventa il paradigma di un mondo fantastico e felice contro gli eccessi della Roma opulenta e lasciva».
Ed infine ecco la filosofia di Lucio Anneo Seneca che affronta Thànatos, non sul versante escatologico, ma su quello esistenziale: con la metafora della clessidra, nella quale la sabbia scende lentamente, e con l’immagine eraclitea del fiume che scorre, illustra il divenire della nostra vita, nella quale “moriamo ogni giorno”, poiché procediamo inesorabilmente verso la fine e ogni momento vissuto è vita sottratta. Quindi se tutto intorno a noi si muove, fugge, è dentro di noi, nella nostra interiorità che dobbiamo ricercare la prima realtà ferma e solida a cui ancorarci. Siamo all’alba del Cristianesimo, che farà della vita interiore uno dei cardini della dottrina di un nuovo mondo e di un uomo nuovo.
Vale dunque la pena mettersi in viaggio con Gabriella Carrano insieme ai grandi dell’antichità per scoprire dimensioni umane oggi forse perdute nelle grandi illusioni tecnocratiche, virtuali, egotistiche, socialmente liquide.
Enzo Concardi
L’AUTRICE
Gabriella Carrano, nata a Salerno ed ivi residente, è titolare di Lettere greche e latine presso il Liceo Classico Torquato Tasso della sua città. Laureata in Lingue e in Lettere classiche, ha ricoperto per diversi anni la docenza a contratto presso l’Università degli Studi di Salerno. Ha pubblicato monografie afferenti all’Anglistica, ma i suoi interessi sono principalmente focalizzati sul mondo antico.
Gabriella Carrano, Èros e Thànatos nel mondo greco-romano, premessa di Enzo Concardi, Guido Miano Editore, Milano 2025, pp. 124, isbn 979-12-81351-43-1, mianoposta@gmail.com.